Navile X per 2‘Navile X per 2’
testo di Viviana Gravano
Spazio inventario, spazio inventato
La “documentazione” fotografica del paesaggio urbano pone questioni essenziali sulle relazioni possibili tra lo sguardo di chi osserva, e il contesto da rappresentare, che non è mai costituito dai luoghi in sé, ma dagli spazi tracciati dalle traiettorie umane che li attraversano, o a volte, che li attraverseranno[2]. Occorre iniziare con il definire cosa si intende per “documento” quando ci si approccia con una materia così indefinita, e sanamente indefinibile, quale è uno spazio urbano popolato di edifici, ma fondamentalmente di una comunità di abitanti. La fotografia, che per sua natura tende a creare frames, quindi nella stessa misura a includere e escludere, non può che fermare un fotogramma di una sequenza infinita che, nel momento stesso in cui viene sviluppata tende è già cambiata. Questa è la ricchezza e insieme la complessità degli spazi urbani. Dunque viene da chiedersi perché documentare, e più che altro, come documentare un luogo in forte trasformazione quale è il Navile di Bologna. Lo storico francese Jacques Le Goff[3], in un noto saggio per Einaudi del 1978, parla di documento/monumento, chiarendo che il documento presenta da un lato lo stesso incarico di essere portatore di memoria, ma dall’altro la stessa drammatica fissità icastica. Per questo Le Goff riscatta il senso della documentazione specificando che questa non può che essere soggettiva, e che non è caratterizzata da nessuna impossibile oggettività, ma se mai al contrario viene improntata proprio alla volontà di chi la realizza di decidere cosa trasmettere alle generazioni future e cosa no.” “Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro – volenti o nolenti – quella data immagine di se stesse. Al limite, non esiste un documento-verità”[4]. Partendo da questo presupposto un lavoro fotografico che sia chiamato a documentare uno spazio urbano, tanto più se in forte trasformazione come è il Navile, può intraprendere tendenzialmente due strade: o giocare sulla freddezza di una “oggettività” simulata, che possiamo dire possa fare riferimento a una tradizione fotografica italiana molto consolidata; oppure può mettere in atto in processo di negoziazione continua tra il proprio spazio soggettivo e i micro mutamenti che lo spazio “reale” sottopone allo sguardo. I due lavori presenti in questo libro sono, a mio modo di vedere, la perfetta esemplificazione delle due scelte appena enunciate: per la prima scelta Fabio Mantovani, per la seconda Luca Capuano. “Mio caro amico, vi invio un piccolo lavoro del quale sarebbe ingiusto dire che non ha né capo né coda, perché, al contrario, in esso tutto è, alternativamente e reciprocamente, a un tempo capo e coda. (…) Togliete una vertebra, e i due pezzi di questa tortuosa fantasia si ricongiungeranno senza sforzo. Spezzatela in mille frammenti, e vedrete che ciascuno potrà vivere separatamente”[5]. Così Charles Baudelaire descrive il suo testo Lo spleen di Parigi che è uno dei pezzi fondamentali del modernismo per capire lo spirito delle nascenti metropoli europee. Vorrei partire da questa visione per leggere il lavoro di Luca Capuano che non ragiona sul catalogo sistematico di un territorio, ma costruisce una narrazione diacronica, frammentata e “dispersiva”, che non segue un filo narrativo ma apre micro-visioni, e micro-conflitti, che rappresentano al meglio la dinamicità del contesto urbano. Ogni immagine potrebbe andare da sola, o al limite in piccole sequenze, e nessuna vive della necessità stringente dell’altra per avere un suo senso, ma nonostante questo, alla fine sentiamo di aver letto un racconto del Navile. E il coraggio di Luca è nel decidere che non possa esistere in nessun modo il racconto, ma semmai un racconto, che potrebbe variare anche se lui stesso lo ricominciasse da capo. Walter Benjamin descrivendo il suo metodo di lavoro per creare i noti Passagenwerk scrive: “Questo lavoro deve sviluppare al massimo grado l’arte di citare senza virgolette. La sua teoria è intimamente connessa a quella del montaggio (…) Quelle che per gli altri sono delle deviazioni sono per me i dati che definiscono la mia rotta”[6]. Il metodo di ricerca di Luca Capuano a mio modo di vedere utilizza uno stesso sistema di citazione, che associa in maniera disseminata diversi aspetti dell’area fotografata, passando dal macro di visioni d’insieme al dettaglio di alcuni interni, dallo sguardo sugli edifici non finiti o in via di ultimazione, agli alberi presenti nelle piccole aree verdi. Il concetto di “deviazione” che propone Benjamin mi sembra particolarmente calzante e importante perché permette di eliminare l’unidirezionalità dello sguardo “documentario” che crea una sorta di cliché in nome di una vagheggiata scientificità della visione. Solo gli scarti permettono di rivelare i conflitti, di far emergere le piccole fratture, che tendono a evocare una realtà non pacificata quale è sempre e comunque la realtà urbana, anche quando si presenta come virtuosa e altamente vivibile. I punti di vista di Luca sono dei piccoli agguati alla nostra visione, ci impediscono di sentirci rassicurati e ci invitano non a contemplare ma a attraversare. Il lavoro di Fabio Mantovani, di segno direi molto diverso, crea una sorta di bolla cristallina, di oggettivizzazione che fa pensare alla fotografia tedesca della scuola di Düsseldorf, che evita il conflitto ponendo lo spettatore in una sorta di limbo. La visione pulita, geometrica, “oggettiva”, costruisce una condizione di attesa, come una grande quinta teatrale montata sul reale che ci mette in ascolto degli eventi. Potremmo mettere a paragone gli approcci dei due lavori in questo libro usando le parole ancora di De Certeau: “(…) la descrizione oscilla fra i termini di un’alternativa: o vedere (è la conoscenza dell’ordine dei luoghi), o andare (sono azioni spazializzanti). O presenta un quadro (“c’è”…), o organizza dei movimenti (“entri, attraversi, vòlti”…)”. Dunque nel caso di Mantovani “c’è” una descrizione dei “luoghi”, nel caso di Capuano si “attraversa” uno spazio di azioni. Sia l’uno che l’altro approccio affrontano in maniera soggettiva il contesto analizzato, ma nell’un caso la scelta personale è quella di restare poi in filigrana, di non apparire, mentre nell’altro la scelta è radicalmente manifesta. Questa distinzione potrebbe essere comunque discussa partendo da un’affermazione del geografo Herbert Lehmann, che potremmo definire uno psicogeografo: “Occorre sottolineare che tale rielaborazione del paesaggio non ha bisogno di essere un atto consapevole, ma che ha luogo anche laddove si è convinti di vedere e riproporre una immagine oggettiva. Qualsiasi raffigurazione o descrizione di paesaggio contiene necessariamente questo momento creativo ‘soggettivo’.[7] Alcune delle immagini di Luca propongono una sorta di sequenze temporali che mostrano uno stesso luogo che si trasforma in maniera lieve, quasi impercettibile al primo sguardo, ospitando le traiettorie di attraversamento delle persone. Queste piccole variazioni ci fanno pensare che la fotografia può anche rappresentare lo sguardo dell’“altro/a”. È come se potessimo vedere quello stesso luogo trasformarsi in uno spazio grazie ai vari punti di vista che lo osservano, anche solo distrattamente percorrendolo. La serie di immagini sul recente Monumento alla Shoà, la fine di via dei Carracci proprio al crocevia, i binari della ferrovia o gli alberi in primo piano presi da più punti di vista, mi hanno fatto subito pensare al film Smoke del 1995 diretto da Wayne Wang, ma scritto e co-diretto da Paul Auster, basato sul suo racconto Il racconto di Natale di Auggie Wren[8]. In una sequenza fondamentale del film Harvey Keitel (nel film Auggie Wren) e William Hurt (nel film Paul Benjamin) guardano un album di foto in cui sono conservate 4000 immagini che Auggie ha scattato sempre allo stesso angolo di strada, quello davanti al suo negozio. Paul non capisce e chiede spiegazioni, ma alla fine capisce solo quando Auggie gli chiede di vederle più lentamente e, nel film, inizia una sequenza di montaggio in cui loro due guardano le foto che noi non vediamo, e poi invece vediamo noi le foto a tutto schermo come fossimo noi a sfogliare l’album. Il banale e casuale “catalogo” di quell’angolo di mondo, del quale Auggie dice che semplicemente lì accade sempre qualcosa come ovunque, mi sembra che pieghi perfettamente come un’immagine serve proprio a spiegare in maniera semplice e chiaro che sono gli sguardi a trasformare i luoghi in spazi. Nella geometria delle immagini di Fabio Mantovani la fotografia trova un suo minimalismo visivo, fatto di segni che si ripetono, e in qualche misura alludono alla possibilità di ricercare un ordine che prescinde dal tempo. Poi improvvisamente siamo proiettati negli interni e appaiono persone, corpi, che in qualche modo si allineano in geometrie simili, divengono parte di un disegno generale. Questa parte del libro lavora sull’ipotesi di poter immaginare di disegnare delle traiettorie visive che possano illustrare, e assecondare, un tentativo dell’architettura e dell’urbanistica di tracciare uno scheletro che non sia una gabbia ma piuttosto un palcoscenico del potenziale. Il tempo del lavoro di Mantovani è fulmineo, folgorante. Non richiede una pausa, non ci fa fermare ma si schiaccia in una bidimensione disegnata che ci aiuta come una mappa a ridurre il luogo a disegno.
[1] Perec G., Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, p. 19. [2] Cfr. De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, 2001. De Certeau intende per luogo qualcosa di stabile e ben identificabile, per luogo la risultanza di tutte le traiettorie che attraversano un luogo modificandolo costantemente. [3] Le Goff, J., Documento/Monumento, Enciclopedia Einaudi, Torino 1978, vol. V, pp. 38 [4] Le Goff, J., op.cit. p.46. [5] Baudelaire,C., Lo spleen di Parigi, Milano, SE, 1988, p. 11 [6] Benjamin W., I “passages” di Parigi, Torino, Einaudi, 2002, p.312. [7] AA.VV., L’anima del paesaggio tra estetica e geografia, a cura di Bonesio L. e Schmidt M. di Friedberg, Milano, Mimesis, 1999 [8] Racconto pubblicato sul New York Times nel 1990 |  'Navile X pr 2' design Rosanna Lama |  |  |  |  |  |  | 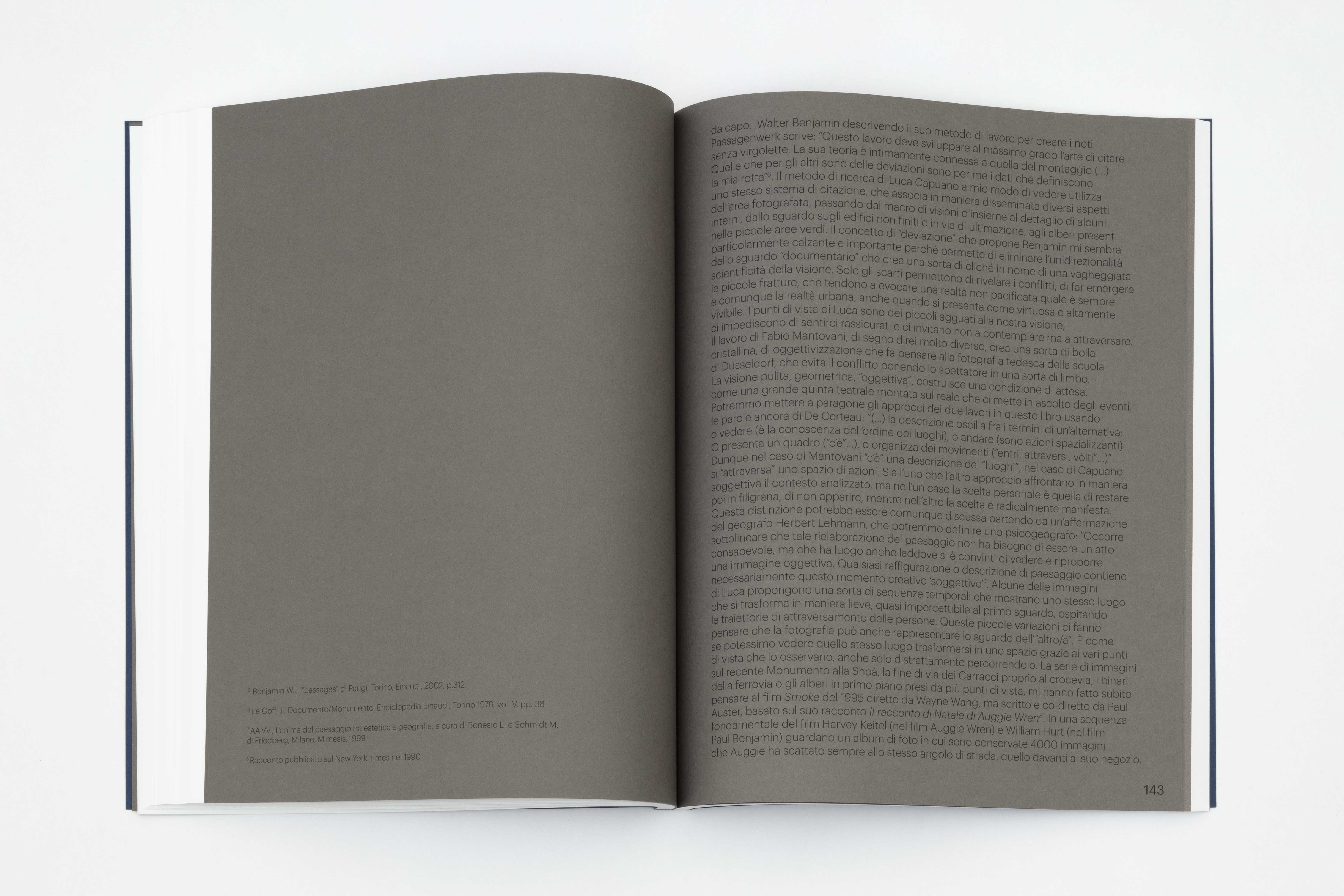 | 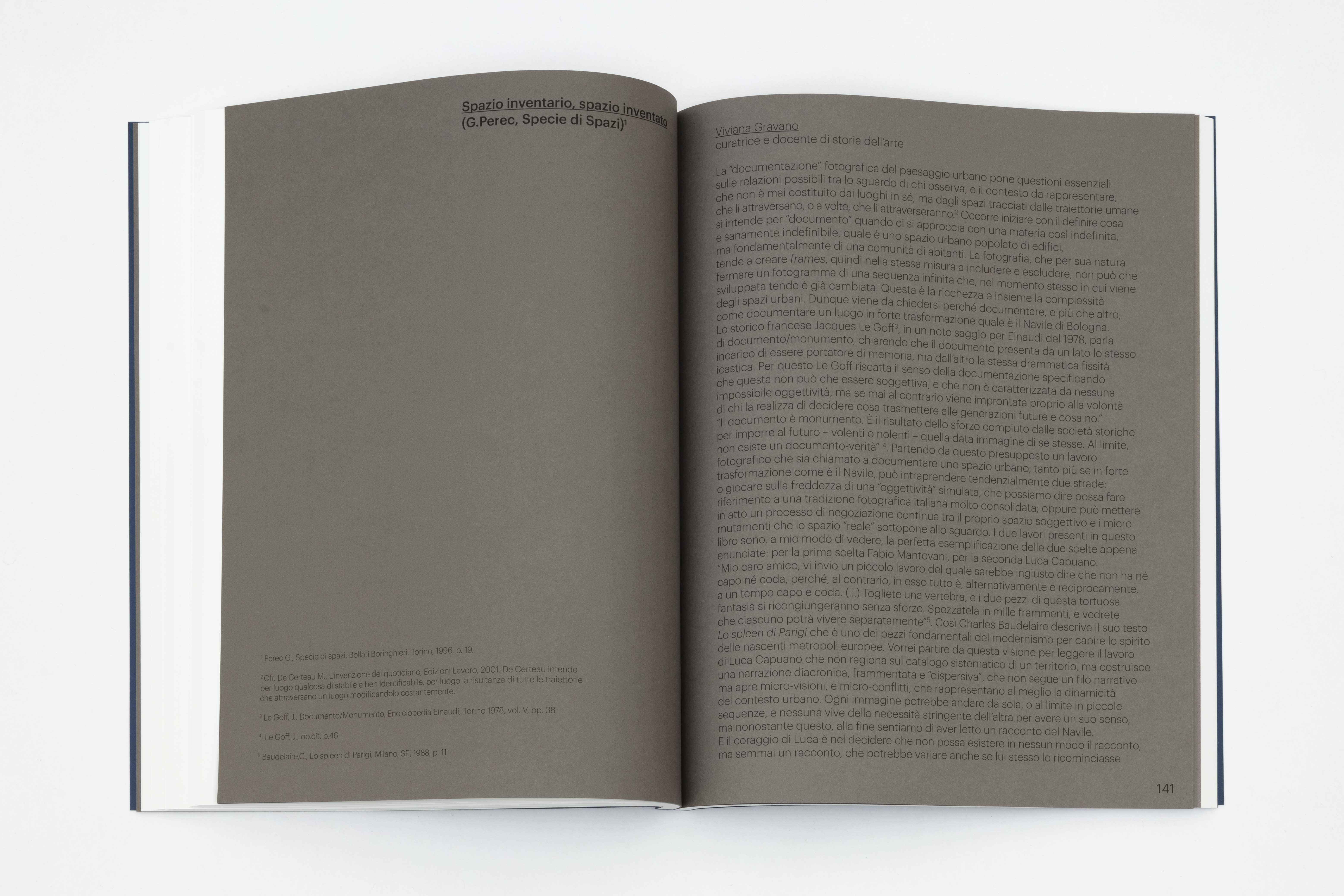 | 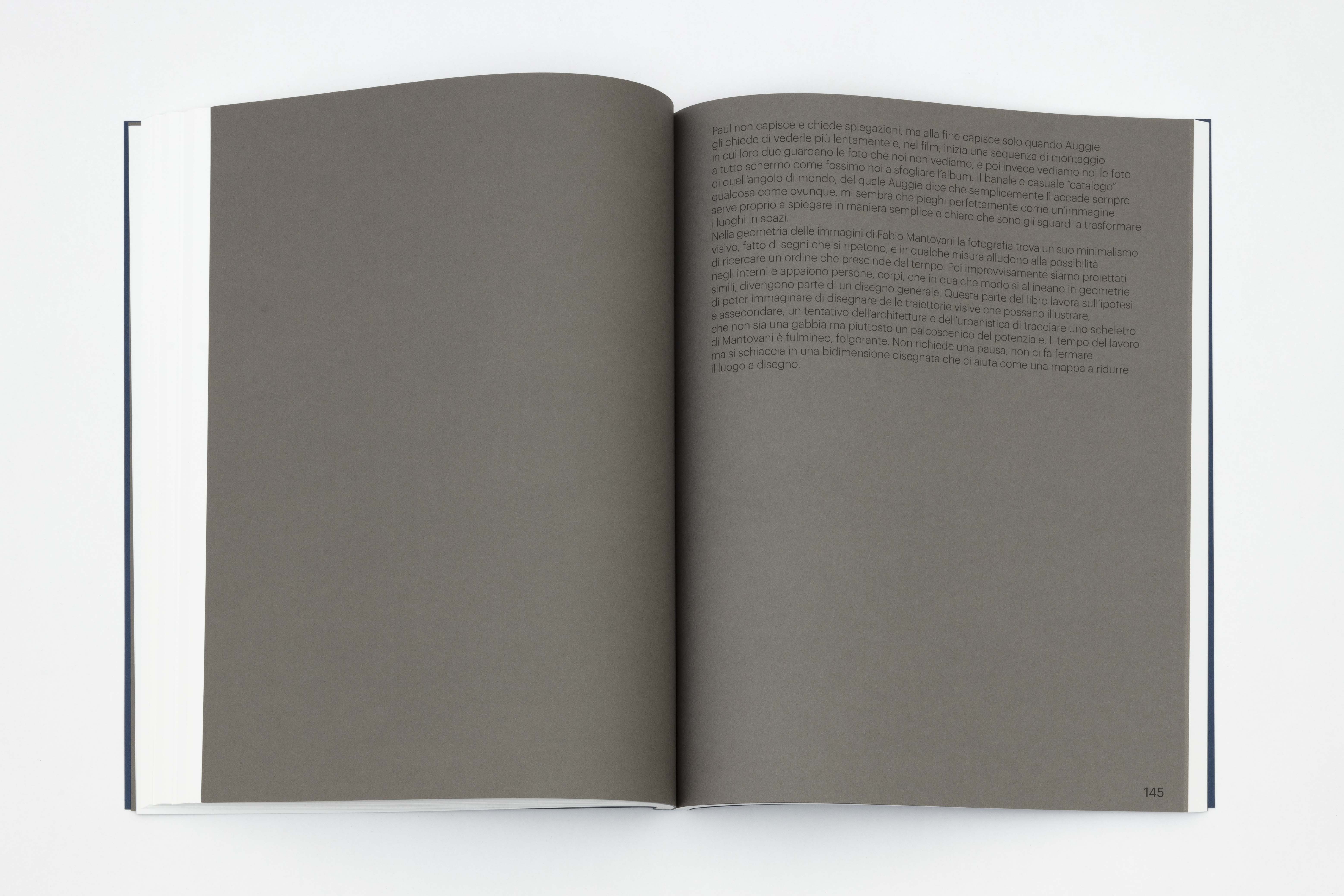 |  |  Sala Borsa, Bologna |  |