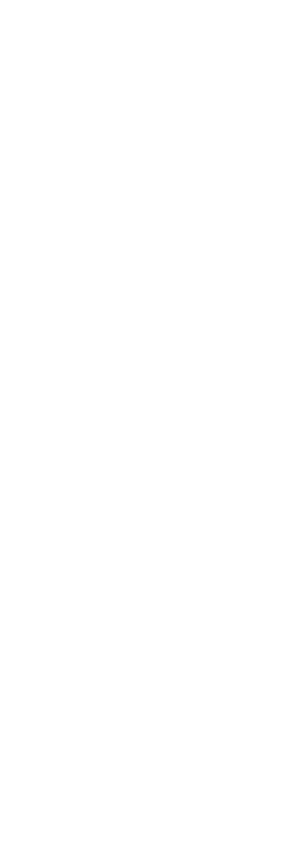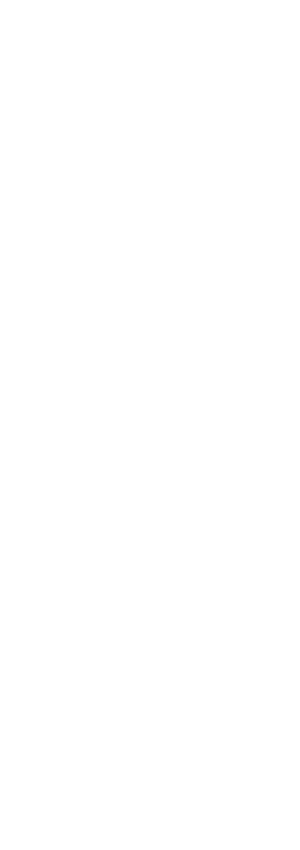La storia di Federico – 2013
Una passeggiata in tandem
di Pierfrancesco Frillici
La storia dell’arte italiana è piena di capolavori. Uno di questi è senza dubbio il ritratto di Federico da Montefeltro, eseguito da Piero della Francesca attorno al 1465. L’opera è costituita da un doppio ritratto. Accanto alla celebre effigie del duca si staglia il volto ceruleo e soave della seconda moglie, Battista Sforza, la donna da lui più amata. I coniugi appaiono intimamente congiunti. I loro profili si rispecchiano l’uno nell’altro come facce indivisibili della stessa medaglia. A coronamento della nobile unione, Piero li ha immersi nello strabiliante scenario della campagna marchigiana, così come, ancora oggi, la si può ammirare dal vivo. Molti studiosi hanno avanzato l’ipotesi, per niente peregrina, che possa trattarsi del panorama realmente visibile dalle torri del palazzo ducale di Urbino.
Il tratto pittorico del maestro delinea i minimi dettagli con precisione lenticolare. È a dir poco superbo nella descrizione del paesaggio; potrebbe essere avvicinato ai fiamminghi, peraltro molto apprezzati dallo stesso duca. Tuttavia, al di là di queste annotazioni stilistiche, il ritratto di Federico nasconde un altro significato: una precisa allusione all’identità e al potere posseduti dal principe rinascimentale, nel pieno rispetto della concezione storico-filosofica dell’Umanesimo. Il duca di Piero diventa la personificazione vivente del potere temporale e dal vertice, non solo metaforico, del suo regno si erge a dominare il mondo intero. Tutto ciò senza agitare la spada, senza alzare la voce, con un gesto pacifico, quasi innocente ma di sublime magniloquenza. Assorto e impenetrabile come un congegno perfetto il suo unico occhio rimasto in vita, dopo che l’altro è caduto in un torneo, si spalanca davanti all’orizzonte. Per poter avere la più ampia visuale, la cronache del tempo narrano che il duca si fosse fatto scalpellare addirittura il naso. Adesso però la sua visione è nitida, cristallina, icastica e va, di fatto, a coincidere con la maturata consapevolezza del potere raggiunto in forza dei vasti territori conquistati. Piero sottolinea tale sicura, inoppugnabile convinzione con una veduta prospettica, corrispondente al punto di vista del duca, di eccellente perspicacia analitica, che si accorda con una fisionomia del profilo pregna di rilievi ad alta fedeltà anatomica. L’insieme figurasfondo chiarisce, in maniera simbolica, il carattere del potere nel suo manifestarsi e si può considerare il miglior epilogo dei lunghi anni trascorsi fra la politica, la diplomazia e la carriera militare. Questo Federico da Montefeltro è andato in cima alla torre più alta e nell’atto stesso di guardare verso l’esterno ha esercitato ciò che Gaston Bachelard chiamava la “contemplazione monarchica”, dando la prova più spettacolare del suo dominio. Innalzarsi, osservare da lontano mettendo a fuoco l’infinitesimale, gli ha permesso di distanziarsi dalle cose “basse” del mondo e, di conseguenza, di distinguersi da esse, assumendone il controllo e il governo. La visione come metafora del potere è la dimostrazione più riuscita del teorema antropocentrico su cui poggia la civiltà del Quattrocento, l’alba della modernità. E tuttavia la cosiddetta “età dell’occhio”, per dirla alla McLuhan, identificherà tutta la storia dei secoli successivi costruendo strumenti e forme simboliche sempre più efficaci in grado di potenziare l’organo sensoriale umano e aumentarne le capacità di dominio, quali saranno la fotografia e poi il cinema. Non voglio arrischiare digressioni poco opportune, ma credo che per introdurre in modo corretto questa mostra non potevo evadere l’argomento. D’altronde le forti suggestioni trasmesse dall’opera di Piero sono alla base di tutto il lavoro fotografico.
All’inizio Luca mi aveva parlato del dittico Montefeltro come di un incontro fortuito. Ne aveva visto una copia a stampa sulla parete di un albergo, durante uno dei suoi tanti viaggi. Fin qui niente di eccezionale: la solita pensioncina a due stelle, il solito arredamento da provincia non certo memorabile. Ciononostante il luogo geografico aveva una sua peculiarità. Era situato nel cuore delle antico ducato di Urbino, a due passi dal centro storico. Questo piccolo hotel periferico era stracolmo di stereotipi commerciali legati alla cultura artistica dell’epoca, perfino l’insegna al neon sulla porta d’ingresso era riuscito a testimoniare la fama intramontabile di Piero. In un certo senso era come se un grande sovrano del XV secolo, dalle altezze siderali del suo palazzo, avesse deciso di scendere sulla terra e mettersi alla stregua del suo popolo, o di ciò che ne rimaneva. Poteva tornare a muoversi nei suoi territori, assistere alla vita quotidiana della gente e farlo senza dover abdicare, in un certo senso, ossia senza rinunciare al controllo e all’esercizio del potere. Tanto più che adesso c’era un nuovo occhio meccanico, erede delle visione prospettica dell’arte, pronto a dargli man forte. Federico e Luca, il duca e il fotografo, potevano marciare finalmente insieme.
Quanto detto, ossia la discesa in campo del principe, ci viene suggerita dalla stampa di apertura. Giganteggia sulle altre, ma non le annulla. È come se desse la spinta alle immagini successive, scattate dal fotografo in prima persona, inaugurando un felice connubio che continuerà per tutto il percorso. Mi piace immaginarlo proprio come un tandem, che va a passeggio senza mete prestabilite, un po’ a zonzo per le strade di questo Montefeltro dei nostri giorni. I due scoprono da subito di avere molto in comune. Amano, per esempio, le immagini, ma pure i loro inganni. Difatti, appena cominciamo a guardare le prime foto, subiamo l’incanto di una realtà in procinto di mescolarsi con l’artificio. Certe persone inquadrate sembrano muoversi con spontanea frenesia, proprio come farebbero nella vita reale, ma qualcosa sembra non tornare. E non appena l’obiettivo si sposta di un metro, capiamo subito il perché. Sono solo copie di carta, immagini di altre immagini, il falso che prova a farsi prendere sul serio. L’inganno, però, è davvero perfetto. E sottolineo l’aggettivo, perché in queste visioni nulla è lasciato al caso. Qualsiasi mossa la macchina fotografica faccia, è sempre ben calibrata. Sia che si tratti della scelta delle proporzioni, dei formati, degli effetti luministici, protende a emulare, a ricomporre con la massima fedeltà la percezione naturale, fisiologica delle cose, senza trucco né manipolazione elettronica. Come non rievocare, a questo punto, la strabiliante iconografia dello “studiolo” di Urbino, l’antro magico del duca Federico, con le sue pareti costellate di mirabili tarsie lignee decorate in trompe l’oeil , i cui prodigi illusionistici producono una continuazione virtuale delle forme dipinte fin nello spazio occupato dallo spettatore. Ma le similitudini non finiscono qui. Le stazioni del nostro viaggio proseguono senza sosta. In un passaggio successivo ancora la figura umana, nella fattispecie il passante comune, è al centro dello sguardo. Sta immobile, immortalato a sua insaputa, trovandosi a interpretare una parte che non avrebbe mai immaginato di fare. Nella stessa sequenza la macchina della visione tenta di “animare” quegli oggetti che, invece, sono per natura rigidi, statici, visualizzando una loro moltiplicazione apparente: in realtà si tratta solo della riproposizione in scatti contigui di elementi analoghi. Le sequenze, come potete vedere, sono molte e molto disseminate. Questo basterebbe a esprimere la sensazione di un movimento continuo. Tuttavia, al fine di
aumentare i giri, il ritmo della “pedalata”, spesse volte, viene fatto ricorso alla diagonale, quella sorta di sguardo obliquo su cui scivola veloce il punto di vista. Il passo, allora, accelera e lo spazio si dilata. Così le immagini non si consumano più tanto in fretta; sembrano durare. Il tempo, ecco la vera parola-chiave. Anche se non risponde a una logica classica di causa-effetto, anche se non procede in modo retto preferendo sviluppi complessi ed eterogenei, fa sentire tutte le sue implicazioni. Luca Capuano, a questo proposito, ama introdurre il concetto di “storie”. Ecco, le sue storie le possiamo percorrere con attenzione e sicurezza, leggere con uno sguardo libero dai vincoli dell’aneddoto e della traduzione letterale. Certo, non possiamo scatenare la nostra “immaginazione senza fili”, perché, sottotraccia, ciascun immagine è allacciate alle altre in modo indissolubile, però stare uniti, stare insieme fra gruppi diversi non significa avere un orientamento univoco e assoluto. La figura astratta più efficacie, almeno credo, per rappresentare questa connessione è quella di una rete, le cui maglie, di volta in volta, si infittiscono o si diradano, i cui nodi si aggrovigliano o si dipanano, eppure l’intreccio resta sempre saldo. E questo grazie alla funzione di controllo, la presa di distanza infallibile, cui questa narrazione visiva fa sempre appello e che conduce appunto ogni libera interpretazione ad assumere i caratteri del possibile e del verosimile, a sposare la logica del senso.
Avvicinamenti, allontanamenti, salti, slittamenti sono sempre eseguiti da un obiettivo distaccato, intollerante dell’errore, avverso alla casualità. Chi viaggia non dimostra di avere il passo incerto del pedone distratto che sbatte ripetute volte contro il mondo. Questa fotografia non cerca di fare gli incidenti, pertanto è decisamente contraria allo stile di guida del reportage, nell’accezione più tradizionale del termine. Il suo impatto a primo acchito letterale, perentorio sulla scena del reale, è solo simulato. Giacché qualunque istante, dopo una prima presa diretta, deve essere rielaborato, messo più a fuoco nell’officina delle idee, e soltanto al termine di un lavoro di montaggio in forma diegetica può uscire allo scoperto. Il potere, in tempo di pace, consiste appunto in questo poter raccontare.
In questo viaggio fra reale e immaginario capita anche di riavvolgere il nastro temporale. Nel presente possono incunearsi immagini con la funzione del flashback. La fotografia ce le propone senza maschere da palcoscenico, senza virare nel fantastico, facendo ricorso all’allusione: gli basta spulciare in un archivio, e l’odierna civiltà delle immagini ne è sovraccarica, riciclare un frammento di memoria qualsiasi, non importa l’origine biografica, l’importante è che calzi a pennello sul personaggio del presente. Prendiamo, ad esempio, la sequenza con i due anziani che camminano lungo il marciapiede. A prima vista sembra un semplice pedinamento, ma se ci fate caso gli esiti sono sorprendenti. Non si fanno pensieri voyeuristici, ma meditazioni poetiche sulle stagioni della vita: la bellezza della perduta giovinezza, cui rimandano appunto i ritagli d’archivio, insieme al suo consumarsi lungo un simbolico viale del tramonto, con tanto di dissolvimento finale in una grande esplosione di luce in cui la forma si cancella, così come la vita umana si spegne. I sentieri su cui transitano i nostri vigili scrutatori continuano a biforcarsi e a moltiplicarsi. Altre storie e altri episodi li attendono. Ma noi, prima che la loro corsa giunga al capolinea, vorremo fermarci ancora un momento. Sul finire del percorso si addensano alcune immagini irregolari, fuori sincrono, fuori orbita. In realtà questo accade, perché la loro apparizione potrebbe verificarsi ovunque. Anche dove non si vedono , implicitamente, ci sono. Aderiscono come ombre tanto alla realtà vista quanto a quella immaginata. Spiegano di
cosa è fatta la visione, perché può essere lettura visiva e al contempo “visura” narrativa, entità ibrida come lo è la natura della fotografia. E da ultimo, la parete con Battista Sforza, l’ultima pagina, la fine del viaggio. Voglio ricordare che in origine il dittico Montefeltro era stato pensato come un libro, che poi non fu realizzato, in cui racchiudere l’immagine del mondo gravitante intorno alla corte dei due sposi. È ormai tempo di scendere dal tandem. Il desiderio di riprendersi la realtà con lo sguardo è stato esaudito, Federico è pronto per tornare a casa.